{{slotProps.data.titolo}}
{{slotProps.data.sottoTitolo}}
{{slotProps.data.anteprima}}
{{slotProps.data.autore}}
{{elencoDettaglioArticolo.sottoTitolo}}
La responsabilità dell’Avvocato per le violazioni deontologiche costituisce una responsabilità “speciale”, autonoma dalla responsabilità civile o penale, che trova fondamento nel ruolo dell’Avvocatura quale “ridisegnato” nella Legge 31.12.2012, n. 247, unica professione menzionata nella Costituzione, per gli obblighi che la specialità della professione comporta, anche come componente dei massimi organi di garanzia e della giurisdizione, e presupposti della esistenza di un organo associativo, l’Ordine, che attribuisce uno status di rilevanza pubblica, e di un organo disciplinare di autodichìa, il Consiglio Distrettuale di Disciplina, cui è riservata la competenza disciplinare.
La diversa tutela giuridica apprestata da tale organo, oltre alla protezione della collettività tipica del processo penale, garantisce la salvaguardia dell’intera categoria forense, in riferimento al ruolo sociale; la funzione disciplinare ha la finalità di assicurare il rispetto delle regole poste a fondamento della professione, che costituiscono l’essenza del sistema etico della categoria, custodito e garantito dagli Avvocati in veste di “giudici” disciplinari, per la valutazione dei comportamenti trasgressivi dei doveri deontologici e per la creazione di una giurisprudenza anche in materia procedimentale.
La funzione disciplinare, esaltando e confermando la autonomia dell’esercizio professionale nell’ambito dell’Ordinamento generale, consegue la finalità di tutelare i beni fondamentali della dignità, intesa come consapevolezza del ruolo dell’Avvocato, e il decoro come espressione della dignità attuata con comportamenti e metodi, ad essa conformi, sia nella attività professionale che nella vita privata e di garantire l’affidabilità della collettività e la tutela dei diritti dei terzi, sotto un profilo tecnico e sotto un profilo etico, nel rispetto dell’in dipendenza e dell’autonomia del professionista legale.
Il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina è regolato dal Titolo V, Legge 31.12.2012, n. 247 e dal Regolamento C.N.F. 21,2.2014, n. 2, che integrando tra loro l’art. 59 e l’art. 10, contengono due fondamentali principi: il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; al procedimento disciplinare, per quanto compatibili, si applicano le norme del Codice di procedura penale.
Consegue la conferma che il procedimento ha natura e carattere amministrativo (C.N.F. Sentenze 29.7.2016, n. 287; 30.12.2016, n. 389; 24.4.2018, n. 33) anche se riveste proprie peculiarità per la incidenza sullo status professionale dell’Avvocato, con ripercussioni sull’attività, sull’onore e sulle persone; per tali ragioni, pur essendo il procedimento ispirato ai principi costituzionali dell’art. 97 della Costituzione, sono state predisposte regole che assicurino le garanzie difensive, con riferimento non già tanto all’art. 111 sul “giusto processo”, ma agli artt. 24 e 25 della Costituzione che assicurano la inviolabilità del diritto di difesa, la istituzione del giudice naturale, oltre agli altri “principi di legalità”.
A conferma della inapplicabilità in toto dei principi del “giusto processo” depone il fatto che nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD (i cui provvedimenti costituiscono “decisioni” diversamente dal procedimento dinanzi al C.N.F. che ha natura giurisdizionale, i cui provvedimenti costituiscono “sentenze”) non esiste il diritto alla difesa tecnica obbligatoria, potendo gli incolpati, anche in riferimento alle loro qualità e competenze professionali, difendersi personalmente e il difensore, eventualmente nominato, non ha diritto ad avvisi e comunicazioni: la “legittimazione” alla autodifesa è stata incidentalmente ribadita da sentenze del C.N.F. (14.4.2016, n. 84; 30.12.2016, n. 389) che hanno ritenuto insussistente l’obbligo di nominare un difensore di ufficio, e negato il “diritto” al rinvio per designare altro difensore in caso di revoca del primo.
Attuazione dei principi di legalità e garanzia di difesa e protezione sono la elezione dei componenti del CDD; la precostituzione, quale “giudice naturale” delle Sezioni; la “neutralità” delle Sezioni deliberanti e giudicanti, non potendo farne parte gli iscritti al medesimo Ordine dell’incolpato, per assicurare la “terzietà”; l’assicurazione dell’attuazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova (sia pure attenuato dall’utilizzabilità di documenti e dichiarazioni assunti nel corso della istruttoria sommaria, in virtù del “sistema” amministrativo); il diritto a esercitare le prerogative difensive tipiche del processo penale accusatorio (cui è fatto esplicito richiamo normativo e regolamentare); l’indicazione della durata massima della preistruttoria sommaria, eseguita dal Consigliere Istruttore, e del completamento del procedimento; la possibilità di avvalersi di astenzione e ricusazione; i termini previsti per il deposito della motivazione delle decisioni.
La presenza di elementi di terzietà è commentata anche dalla Corte di Cassazione SS.UU. con la Sentenza 23.6.2017, n. 16993 che nel confermare la natura amministrativa del procedimento ha ribadito la sua natura “giustiziale” che necessita particolari garanzie. La attività difensiva può essere compiuta nel corso della fase istruttoria sommaria, sia pure con garanzie “affievolite” rispetto a quella apprestate nel corso del- la istruttoria formale che consegue alla comunicazione della approvazione del capo di incolpazione, perchè nell’avviso di avvìo del procedimento, formulato dal Consigliere Istruttore ai sensi dell’art. 58, comma 2, Legge 31.12.2012, n. 247 e dall’art. 15 Reg. C.N.F. 21.2.2014, n. 2, è fatta indicazione della facoltà del destinatario di allegare proprie deduzioni difensive e produrre documenti giustificativi; è comunque compito dell’Istruttore individuare fatti e circostanze favorevoli all’interessato che può anche chiedere di essere ascoltato.
Con l’approvazione del capo di incolpazione, che deve contenere, per garantire il diritto di difesa, una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati (come ribadito dal C.N.F. e dalla Corte di Cassazione SS.UU., recentemente con Sentenza 25.1.2019, n. 8313), introducendo la istruttoria formale, il diritto di difesa diviene pieno ed effettivo, potendo l’incolpato, una volta noto l’addebito, chiedere di rendere interrogatorio di “garanzia” (con o senza la presenza di difensore), e spiegare le ragioni motivate e documentate a sostegno di richieste istruttorie e di merito, adeguate e commisurate al contenuto dell’addebito.
La citazione a giudizio, ove approvata dalla Sezione deliberante, contiene l’invito alla nomina di difensore; la comunicazione che si procederà in caso di mancata partecipazione non giustificata da legittimo impedimento (dell’incolpato e non già del difensore); l’avviso che l’incolpato nel termine di sette giorni prima dell’udienza ha diritto a produrre documenti, a indicare testimoni sulle posizioni da esaminare, delineando similmente all’art. 468 c.p.p., il thema probandum e il thema decidendum.
Nel dibattimento l’incolpato può esercitare il diritto alla prova, essendo garantito il pieno contraddittorio ai sensi dell’art. 59, comma 6, lett. e), Legge 31.12.2012, n. 247, anche con il P.M. eventualmente presente; può produrre nuovi documenti, interrogare e far interrogare i testimoni, rendere dichiarazioni spontanee, sottoporsi all’esame; considerata la natura amministrativa del procedimento all’esame di testi e incolpato procede la Sezione decidente; al difensore e all’incolpato spetta l’ultima parola. In apertura del dibattimento l’incolpato può sollevare eccezioni preliminari, anche di nullità (per esempio nel caso venga omesso l’interrogatorio di “garanzia”), sia relative agli atti prodromici del dibattimento; le disposizioni che disciplinano l’attività difensiva nel dibattimento sono ricalcate su quelle del c.p.p., improntate al sistema accusatorio.
Il Presidente della Sezione vigila sull’andamento delle prove procurando che l’esame verta su fatti specifici, vietando le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte e che non sia leso il rispetto delle persone, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e delle contestazioni, decidendo senza formalità sulle questioni, assicurando la speditezza del dibattimento; può indicare alle parti temi nuovi e più ampi, utili per la completezza dell’esame.
Completata l’istruttoria dibattimentale la Sezione, ai sensi dell’art. 59, comma 6, lett. g) indica le dichiarazioni, i documenti, gli atti formati acquisiti anche nel corso della istruttoria preliminare, utilizzabili ai fini della decisione, compresi gli esposti e le segnalazioni contenuti nella “notitia criminis”. Il sistema tendenzialmente accusatorio dell’impianto processuale disciplinare subisce un “affievolimento” e una “svolta” inquisitori, determinati dalla natura amministrativa del procedimento.
La Sezione giudicante nella valutazione delle prove deve attenersi ai principi stabiliti dal Codice di procedura penale all’art. 192, commi 1 e 2, procedendo a valutare, e ponendo a fondamento della motivazione, i risultati acquisiti e i criteri adottati, applicando il metodo del dubbio ai sensi della Legge 20.2.2006, n. 46 che a modifica dell’art. 533 c.p.p. ha fissato come rgola di giudizio il metodo legale del dubbio e tenendo presente il principio del favor rei, essendo superato il concetto disposto per il procedimento amministrativo in genere che l’incolpato debba fornire la prova liberatoria della responsabilità, essendo ormai consolidato l’orientamento secondo il quale anche il procedimento disciplinare è governato da tale principio, confermato dalla Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza 7.4.2018, n. 17534, essendo mutuato il principio del favor rei dai criteri di garanzia che il processo penale riserva all’imputato.
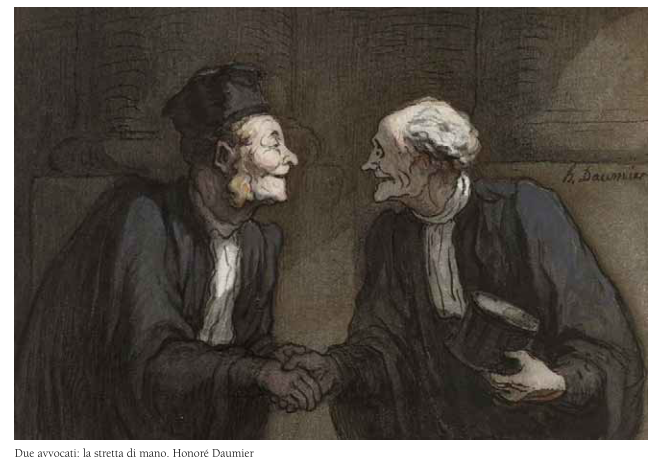
{{slotProps.data.sottoTitolo}}
{{slotProps.data.anteprima}}
{{slotProps.data.autore}}
Categoria